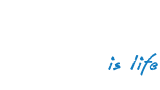L’architettura italiana del primo periodo post-bellico è ancora legata agli schemi tradizionali, benché l’espansione dei linguaggi contemporanei in Europa la rende sempre più permeata a innovazioni nelle forme e nei materiali utilizzati. Lo stile barocco, il recupero del gotico e delle forme rinascimentali lasciano spazio, già nei primissimi anni Venti, al razionalismo italiano.
In questo periodo anche l’architettura subisce un notevole cambiamento, visibile soprattutto nelle “Città Nuove”, come Pomezia, e nei coevi borghi e quartieri, come il quartiere EUR a Roma, realizzati in tutta Italia durante il Governo Mussolini. Un linguaggio, quello razionalista, che richiama il mito imperiale romano e le pulsioni rinascimentali, ma anche il primo Ottocento tedesco.
Il manifesto è lanciato nel 1926 dal cosiddetto Gruppo 7, che include gli architetti operanti a Milano Figini, Pollini, Frette, Larco Silva, Rava, Terragni e Castagnoli. L’obiettivo è semplice ma ambizioso: combinare la monumentalità con la funzionalità, eliminare l’eccessivo decorativismo e le sovrastrutture per dare agli edifici un aspetto solenne e austero come impone la politica dell’epoca. La bellezza non andrà più ricercata negli stucchi o nelle merlature bensì nel succedersi armonico di geometrie lineari e tutte simili nello slancio verso l’alto che per la prima volta disegna un diverso skyline italiano.
Il razionalismo del Ventennio non è collegato al futurismo di Marinetti, del quale costituisce piuttosto una “normalizzazione”: le forme vagamente spaziali, ispirate dalla fantascienza e dalla letteratura di svago sono sostituite dalle esigenze di una politica accentratrice, desiderosa di modernizzare il paese e imporre una visione univoca.
Ecco che nascono i grandi edifici delle Poste e Telegrafi, sorgono ampie piazze monumentali e si aprono vialoni dalle larghezze mai immaginate prime (basti pensare al Viale della Conciliazione di Roma. Uno degli esempi di questo utilitarismo architettonico è ben evidente nella Casa del fascio, edificio che caratterizza tutte le “Città Nuove”, sede degli uffici locali del PNF.
La Città di Pomezia conserva, come da progetto originario, una piante urbanistica semplici, essenziale ma funzionale. Caratterizzata da un ampio viale centrale (le attuali Via Roma e Via Virgilio) e da un’ampia piazza (Piazza Indipendenza) sulla quale affacciano gli edifici di maggiore rappresentanza amministrativa, politica e religiosa. Razionalismo significa infatti prediligere linee dritte, sobrie sia pur tuttavia ammorbidite dal susseguirsi di archi a tutto sesto che legano tra loro le architetture. Tutto risponde a una logica progettuale basata sulle forme essenziali.
Al progetto pometino lavorano il gruppo 2PST, formato dagli architetti Concezio Petrucci e Mario Tufaroli Luciano insieme agli ingegneri Emanuele Filiberto Paolini e Riccardo Silenzi, già autori della Città di Aprilia. Un monumentalismo, il loro, solenne, evidente nella Casa comunale e nell’Edificio della Posta, così come nella Torre civica, con pianta quadrangolare a tre ordini, sormontata da una pseudo-merlatura che richiama gli stili medievale e rinascimentale a imitazione degli antichi castelli.
Dal punto di vista urbanistico e architettonico è tutto accuratamente studiato e finalizzato alla ottimizzazione funzionale degli spazi. In questo caso, Pomezia è esempio rigoroso e vivo di uno stile che sarebbe sopravvissuto alle vicende storiche fino agli anni Settanta del Novecento.